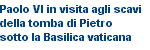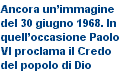Paolo VI e la proclamazione dell’anno della fede, nel 1967, in occasione dei 1900 anni dal martirio di Pietro e Paolo a Roma. Un anno decisivo che si chiuderà con il Credo del popolo di Dio per «attestare il nostro incrollabile proposito di fedeltà al Deposito della fede». «Non possiamo minimamente ignorare che i nostri tempi richiedono questo con forza»
di Gianni Valente
Ci sono momenti, scrive Charles Péguy, in cui cadono tutte le maschere e nulla nasconde più la realtà, che ci appare nuda, così come veramente è. «Sono i soli momenti della vita in cui non si menta; in cui non si simuli affatto; in cui si sia sinceri; letteralmente, assolutamente, totalmente sinceri; in cui si vede il vero, più del vero, il reale, come esso è; in cui non ci si nasconde più niente». Sono questi i momenti in cui «vediamo chiaro, osiamo veder chiaro».
A Paolo VI, esattamente trent’anni fa, capitò di vivere un momento così. Guardò la Chiesa, che, come testimonia la sua prima enciclica, sapeva bene che era di un Altro, cioè di Cristo (Ecclesiam suam), guardò attraverso tutte le buone intuizioni, le ingenue attese, le illusioni e le chiacchiere che in quegli anni l’avevano travolta, e vide. Vide la fine del cristianesimo. Non delle strutture, delle riunioni, del Vaticano, dei piani pastorali, dei raduni oceanici, che potrebbero continuare come coreografie ad uso di chi cerca ruoli ecclesiastici e consolazioni religiose con cui riempire la vita (e magari ci fa su anche carriera). Quella che vedeva spegnersi era la fede. Il nostro tempo come un lungo sabato santo, come il tempo dell’assenza di Dio, quando anche gli ultimi discepoli si preparano tristi e col cuore spento a tornare ognuno a casa sua.
Paolo VI vide tutto questo e, nella tragedia in cui la Chiesa versava, tornò a ricordarle e a ripeterle quali erano i suoi unici tesori: la fede degli apostoli, custodita dalla Tradizione (Credo del popolo di Dio), e i poveri, i popoli della fame (Populorum progressio) chiamati per primi a godere della grazia della fede. Ripetere le cose di sempre, un Papa non può e non deve far altro.
Era il 22 febbraio 1967, quando papa Montini, con l’esortazione apostolica Petrum et Paulum apostolos, indisse un anno giubilare particolare: l’anno della fede. Millenovecento anni prima, i due apostoli Pietro e Paolo erano stati martirizzati a Roma. Uccisi, come ricorda un passo della lettera di san Clemente papa ai Corinzi riportato all’inizio della stessa esortazione apostolica, «a causa della gelosia e dell’invidia», ossia anche per la cattiveria di cristiani. In quell’anniversario, – chiedeva il Papa – tutta la Chiesa era chiamata a far memoria della fede trasmessa in eredità dai due apostoli, nella domanda umile di poter fare della realtà di quella fede la loro stessa viva esperienza, di poter incontrare e sorprendere i gesti di quella stessa Presenza che duemila anni prima aveva attratto gli occhi di poveri pescatori e di grandi peccatori e commosso il loro cuore.
| Quell’anno – oggi lo riconoscono anche gli storiografi più attenti – segnò un crinale, una "svolta" nel pontificato montiniano. Alla fine dell’anno della fede Paolo VI pronunziò in piazza San Pietro una solenne professione di fede, il Credo del popolo di Dio, con cui intendeva «attestare il nostro incrollabile proposito di fedeltà al Deposito della fede». Ma i cattolici di allora non colsero l’intuizione tragica e profetica di papa Montini. Gli illuminati dissero che si trattava di pessimismo eccessivo. Per i reazionari si trattava di pentitismo tardivo, visto che secondo loro la catastrofe era stata innescata da quel rinnovamento conciliare di cui Montini era stato il timoniere. Per i chierici di ogni tendenza, la semplice riproposizione dei contenuti tradizionali della fede cattolica era una risposta troppo minimale davanti alle provocazioni della storia e anche alla crisi della Chiesa. Secondo loro occorreva una strategia più complessa: bisognava coscientizzare, ovvero rendere cultura la fede. Per entrare in dialogo e adeguarsi al mondo – dicevano gli uni. Per resistere all’assedio della modernità e combattere – dicevano gli altri. Così l’anno della fede e il Credo del popolo di Dio furono inghiottiti in un gorgo di silenzio. | 
 |
Inimici hominis, domestici eius
A turbare papa Paolo VI non era tanto l’immoralità del mondo, o la negazione teorica del cristianesimo a quel tempo sfacciata e violenta.
Già negli anni che precedono il ’67, l’allarme contenuto nei discorsi di Paolo VI è un altro: la Chiesa viene demolita non dall’ateismo moderno, ma dai suoi stessi figli. La malattia è interna, è un cupio dissolvi che sembra aver avvelenato i maestri, i chierici e le accademie ecclesiastiche, prima ancora che il popolo, e li spinge a uno svuotamento dall’interno della natura e del metodo del fatto cristiano. «Vengono alle labbra le parole di Gesù: "inimici hominis, domestici eius", i nemici dell’uomo saranno i suoi di casa!», dirà il Papa il 18 settembre 1968, a nemmeno tre mesi dalla proclamazione del Credo. Ma già nel ’65, all’udienza generale del 4 agosto, il Papa si diceva preoccupato per «le voci provenienti anche dai campi migliori del popolo di Dio, dove ordinariamente la dottrina della Chiesa è alimentata da fervore di studi, è coltivata con fermezza di pensiero», che oggi fanno eco «ad errori antichi e moderni, già rettificati e condannati dalla Chiesa ed esclusi dal patrimonio delle sue verità». L’11 luglio del ’66, parlando a un gruppo di teologi e scienziati riunitisi per aggiornare la modalità di presentazione del dogma del peccato originale, Paolo VI li mette in guardia dall’acconsentire a formulazioni del peccato originale che siano subordinate alla teoria dell’evoluzionismo. Ma è all’udienza generale del successivo 30 novembre che Paolo VI descrivendo «il triste fenomeno che turba il rinnovamento conciliare e sconcerta il dialogo ecumenico», chiarisce nel dettaglio quali siano le cose essenziali del cristianesimo che si tenta di svuotare: «La resurrezione di Cristo, la realtà della sua vera presenza nell’eucaristia, ed anche la verginità della Madonna e di conseguenza il mistero augusto dell’incarnazione». Nell’ottobre ’66 era stato pubblicato il nuovo Catechismo olandese, voluto dall’episcopato d’Olanda, il prototipo di quei catechismi post-conciliari che pensano di rendere interessante il cristianesimo per l’uomo moderno sostituendo alle tradizionali formule di fede discorsi complicati e in talune parti ambigui e reticenti. Il 7 aprile dell’anno successivo, parlando all’assemblea dei vescovi italiani, Paolo VI ribadisce quale sia la priorità: «La prima questione, questione capitale, è quella della fede, che noi vescovi dobbiamo considerare nella sua incombente gravità. Qualcosa di molto strano e doloroso sta avvenendo… anche fra coloro che conoscono e studiano la parola di Dio: viene meno la certezza nella verità obiettiva e nella capacità del pensiero umano di raggiungerla; si altera il senso della fede unica e genuina; si ammettono le aggressioni più radicali a verità sacrosante della nostra dottrina, sempre credute e professate dal popolo…».

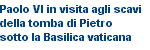 | La Tradizione che ci precede
Addolora Paolo VI soprattutto chi in quest’opera di autodemolizione strumentalizza l’ultimo Concilio ecumenico, interpretandolo come l’atto di nascita di un nuovo cristianesimo e di una nuova Chiesa. Ad un anno esatto dalla sua chiusura (discorso dell’8 dicembre 1966) Montini denuncia l’errore di supporre che il Vaticano II «rappresenti una rottura con la tradizione dottrinale e disciplinare che lo precede». Quasi un mese prima, nell’udienza generale, aveva invitato a resistere alla tentazione di credere «che le novità, derivate dalle dottrine e dai decreti conciliari, possano autorizzare qualsiasi arbitrario cambiamento… Bisogna essere profondamente convinti che non si può demolire la Chiesa di ieri per costruirne una nuova oggi; non si può dimenticare e impugnare ciò che la Chiesa ha finora insegnato con autorità per sostituire alla dottrina sicura teorie e concezioni nuove». |
Il 12 gennaio 1966 aveva detto: «Gli insegnamenti del Concilio non costituiscono un sistema organico della dottrina cattolica» la quale «è assai più ampia… e non è messa in dubbio dal Concilio o sostanzialmente modificata; ché anzi il Concilio la conferma, la illustra, la difende e la sviluppa con autorevolissima apologia… Non sarebbe quindi nel vero chi pensasse che il Concilio rappresenti un distacco, una rottura, ovvero, come qualcuno pensa, una liberazione dall’insegnamento tradizionale della Chiesa».
La fede, adesione a una testimonianzaDavanti a ciò che vede, Paolo VI sa bene che non basta rintuzzare gli errori dottrinali che serpeggiano tra la leadership cattolica. La confusione dottrinale è il sintomo di qualcosa di più radicale. Sembra quasi che dovunque, nella Chiesa, si vada perdendo la percezione di cosa sia veramente il cristianesimo, la natura e la dinamica della vita cristiana. Non si sa più di cosa si tratta.
Il Papa decide di approfittare dell’anniversario del martirio dei santi apostoli Pietro e Paolo per indire l’anno della fede quale risposta alla vertiginosa smemoratezza seguita all’ebollizione conciliare.
Nell’esortazione apostolica Petrum et Paulum apostolos, che indice l’anno della fede, gli accenni alla crisi dottrinale sono pochi e secondari. L’unica, semplice e minimale richiesta rivolta a tutti i figli della Chiesa è quella di ripetere la professione di fede degli apostoli Pietro e Paolo, di rimanere in questa fede. «Vogliamo inoltre chiedere una cosa piccola ma importante: vogliamo pregare tutti voi singolarmente, fratelli e figli nostri, di fare memoria dei santi Apostoli Pietro e Paolo, che testimoniarono la fede di Cristo con le parole e col sangue, in modo da professare con verità e sincerità la medesima fede che la Chiesa, fondata e resa splendida da loro stessi, accolse devotamente e espose con autorità. D’altronde questa professione di fede, che, avendo per testimoni i beati Apostoli, rendiamo a Dio, conviene certo che sia individuale e pubblica, libera e consapevole, interiore ed esteriore, umile e decisa. Vorremmo inoltre che una tale professione di fede scaturisse dall’intimo del cuore di ogni uomo, e riecheggiasse una sola, identica e traboccante d’amore in tutta la Chiesa. Infatti quale più grato servizio di memoria, di onore, di comunione potremmo noi offrire a Pietro e Paolo che la dichiarazione di quella fede che abbiamo ricevuto da loro stessi quasi in eredità?». Il ripetere le formule che custodiscono la fede apostolica non risponde solo ad una devozione, ma è per Paolo VI un gesto realmente adeguato al momento storico che la Chiesa vive: «Non possiamo minimamente ignorare che i nostri tempi richiedono questo con forza».
Numerosi discorsi di quel periodo chiariscono e commentano il perché dell’anno della fede di Pietro e di Paolo. All’udienza del primo marzo ’67, pochi giorni dopo l’esortazione apostolica, Paolo VI spiega: «Ci sembra che questo tema offra a noi il filo più sicuro e più diretto per comunicare spiritualmente con quei grandi Apostoli; loro stessi ne hanno lasciato pressante raccomandazione; dice, ad esempio, san Pietro, nella sua prima lettera ai primi cristiani che essi sono "custoditi nella fede per la salvezza"», e anche san Paolo «è preso dall’ansia di garantire l’integrità e la conservazione della fede, e ripete le sue raccomandazioni perché ogni errore sia evitato e respinto e perché il "depositum sia custodito". […] Aderendo alla fede, che la Chiesa ci propone, noi ci mettiamo in comunicazione diretta con gli Apostoli che vogliamo ricordare; e, mediante essi, con Gesù Cristo, nostro primo e unico Maestro; noi ci mettiamo alla loro scuola, annulliamo la distanza dei secoli, che da loro ci separano e facciamo del momento presente una storia vivente, la storia sempre uguale a se stessa propria della Chiesa». La fede, spiega nello stesso discorso papa Paolo VI, ricorrendo alla definizione del Concilio di Trento, «"humanae salutis initium est", è il principio per l’uomo della sua salvezza».
Anche nell’udienza del successivo 19 aprile il Papa si sofferma a chiarire cosa sia la fede cristiana, distinguendola dalla assimilazione comunemente fatta «col sentimento religioso, con la credenza vaga e generica dell’esistenza di Dio». La fede, dice Paolo VI, è «l’adesione dello spirito, intelletto e volontà, ad una verità» che si giustifica «per l’autorità trascendente di una testimonianza, a cui non solo è ragionevole aderire, ma intimamente logico per una strana e vitale forza persuasiva, che rende l’atto di fede estremamente personale e soddisfacente». La fede è dunque «una virtù che ha le sue radici nella psicologia umana, ma che deriva la sua validità da una azione misteriosa, soprannaturale, dello Spirito Santo, della grazia infusa in noi, in via normale, dal battesimo». È «quella capacità spirituale che ci fa accogliere, come corrispondenti alla realtà, le verità che la parola di Dio ci ha rivelate. È perciò la fede un atto che si fonda sul credito che noi diamo al Dio vivente».
L’inaugurazione ufficiale dell’anno della fede viene celebrata solennemente sul sagrato della basilica vaticana la sera del 29 giugno 1967, festa dei santi Pietro e Paolo.

 | Nell’omelia il Santo Padre ribadisce che «il Concilio ecumenico, testé celebrato, ci ha esortato a risalire alle sorgenti della Chiesa e a riconoscere nella fede il suo principio costitutivo, la condizione prima d’ogni suo incremento, la base della sua sicurezza interiore e la forza della sua esteriore vitalità». Qualche giorno dopo, i pellegrini presenti all’udienza del 5 luglio possono ascoltare nuove parole del Papa sulla fede: «La fede è l’eredità degli Apostoli. È il dono del loro apostolato, della loro carità. […] Il fatto ch’essi, insieme con gli altri apostoli e con gli annunciatori autorizzati del Vangelo, sono gli intermediari tra noi e Cristo, caratterizza il cristianesimo in modo essenziale e genera un sistema di rapporti indispensabili nella comunità dei credenti. |
[…] L’Apostolo è maestro; non è semplicemente l’eco della coscienza religiosa della comunità; non è l’espressione dell’opinione dei fedeli, quasi la voce che la precisa e la legalizza, come dicevano i modernisti, e come ancora oggi alcuni teologi osano affermare. La voce dell’Apostolo è generatrice della fede. […] La verità religiosa, derivante da Cristo, non si diffonde negli uomini in modo incontrollato e irresponsabile; essa ha bisogno di un canale esteriore e sociale».
L’Oriente dei grandi Concili
Il viaggio in Turchia, che il Papa visita tra 25 e il 26 luglio, è un ulteriore passo sulle orme della memoria apostolica, secondo l’intenzione dell’anno della fede. Il Papa incrocia gli itinerari che Paolo percorse durante la sua predicazione, «fondando le prime comunità cristiane, in mezzo alle peripezie, a volte drammatiche, raccontate negli Atti degli apostoli», come ricorda il Papa ad Efeso, nella chiesa di San Giovanni. Ma il filo rosso del viaggio è il ritorno nei luoghi in cui furono celebrati i primi grandi Concili che definirono e custodirono la fede apostolica, difendendo il cristianesimo dalle antiche eresie. Tornato a Roma, all’Angelus del 2 agosto il Papa celebra la preminenza dei primi quattro Concili ecumenici svoltisi in Oriente (Nicea, Costantinopoli, Efeso, Calcedonia). Un indiretto ridimensionamento della portata dell’ultimo Concilio ecumenico, che alcuni vorrebbero celebrare come l’anno zero della Chiesa. «Questi quattro Concili – dice il Papa – furono e rimangono degni di grande riverenza. Furono essi che diedero alla Chiesa, dopo i primi secoli di vita perseguitata e quasi clandestina, la coscienza della sua compagine costituzionale e unitaria. Furono essi che misero in evidenza e stabilirono in autorità i dogmi fondamentali della nostra fede, sulla Santissima Trinità, su Gesù Cristo, sulla Madonna: e che perciò diedero al cristianesimo la sua dottrina basilare». L’atto di venerazione nei confronti dei primi quattro Concili ecumenici diventa anche spunto per ribadire la comunione di fede con gli Ortodossi nei dogmi fondamentali. Paolo VI, il papa che ha cancellato le scomuniche reciproche tra Roma e Costantinopoli e che più in là si inchinerà a baciare i piedi del vescovo ortodosso Melitone di Calcedonia, durante il viaggio in Turchia approfitta degli incontri con il patriarca Atenagora e con gli ortodossi di Efeso per ripetere che «per ristabilire e conservare la comunione e l’unità, occorre infatti essere attenti a "non imporre niente che non sia necessario"». «La carità» dice ad Atenagora e ai metropoliti del Patriarcato ecumenico, nella cattedrale di San Giorgio «ci deve aiutare come ha aiutato Ilario e Atanasio a riconoscere l’identità della fede al di là delle differenze di vocabolario in un momento in cui gravi divergenze dividevano l’episcopato. […] E san Cirillo d’Alessandria non accettò forse di mettere da parte la sua teologia così bella per fare la pace con Giovanni d’Antiochia, dopo essersi accertato che al di là di espressioni differenti, la loro fede era la stessa?».
I riferimenti umani e materiali della memoria
Alla fine dell’anno della fede Paolo VI scandalizza i chierici con due gesti clamorosi. Il 26 giugno 1968, con un’allocuzione nella Basilica vaticana, annuncia l’autenticità delle reliquie di san Pietro, rinvenute durante i lavori nelle grotte vaticane tra il 1940 e il 1950. «A questa intensità di sentimenti» dice papa Montini «ci aiutano e ci impegnano le tracce storiche e locali da loro lasciate. Non possono essere trascurati da noi romani, e da quanti a Roma muovono i passi, questi riferimenti umani e materiali alla memoria degli Apostoli, "per quos religionis sumpsit exordium", per merito dei quali iniziò la nostra vita religiosa». Il risultato delle indagini sui frammenti ossei ritrovati nella necropoli vaticana viene annunciato con trattenuto entusiasmo: «Nuove indagini pazientissime e accuratissime furono in seguito eseguite con risultato che Noi, confortati dal giudizio di valenti e prudenti persone competenti, crediamo positivo: anche le reliquie di san Pietro sono state identificate in modo che possiamo ritenere convincente, e ne diamo lode a che vi ha dedicato attentissimo studio e lunga e grande fatica».
| Il 30 giugno 1968 una solenne liturgia chiude l’anno della fede, con la professione di fede che Paolo VI stesso definisce Credo del popolo di Dio. È il coronamento dell’anno della fede, «che avevamo dedicato – spiega Paolo VI nell’omelia – alla commemorazione dei santi Apostoli per attestare il nostro incrollabile proposito di fedeltà al Deposito della fede che essi ci hanno trasmesso, e per rafforzare il nostro desiderio di farne sostanza di vita nella situazione storica in cui si trova la Chiesa pellegrina nel mondo». Con tale professione Paolo VI intende adempiere il mandato, «affidato da Cristo a Pietro, di cui siamo il successore, sebbene l’ultimo per merito, di confermare cioè nella fede i fratelli. Il nuovo Credo, «senza essere una definizione dogmatica propriamente detta, e pur con qualche sviluppo, richiesto dalle condizioni spirituali del nostro tempo, riprende sostanzialmente il Credo di Nicea». Nel professare il Credo del popolo di Dio, Paolo VI dichiara di aver presente «l’inquietudine che agita alcuni ambienti moderni» e «la passione per il cambiamento e la novità» che ha preso molti cattolici: «è necessario avere la massima cura di non intaccare gli insegnamenti della dottrina cristiana. Perché ciò vorrebbe dire – come purtroppo oggi spesso avviene – un generale turbamento e perplessità in molte anime fedeli». | 
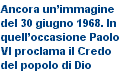 |
Un grande papa in tempi difficili. Come scrisse allora Carlo Falconi, leader dei vaticanisti del tempo, nel suo libro La svolta di Paolo VI, «l’enorme gorgo di silenzio che ha risucchiato la proclamazione del nuovo Credo è drammaticamente minaccioso. Tutta la campagna interventista del quotidiano vaticano, per fingerle un’eco commossa e riconoscente di consenso, è finita nel vuoto. E se non fosse seguita presto la pubblicazione dell’enciclica Humanae vitae, convogliando su di sé la più aperta reazione, l’imbarazzo di quel silenzio protestatario avrebbe toccato il limite del sopportabile».
Tutto l’establishment cattolico, salvo rare eccezioni, lascia cadere nel nulla la lucida intuizione della condizione della Chiesa nel mondo espressa dall’anno della fede e dal Credo del popolo di Dio. Per teologi e intellettuali si tratta di "atti pietistici". All’inizio dell’anno della fede, il teologo olandese Edward Schillebeeckx, commentando l’iniziativa di Paolo VI, afferma che la crisi attraversata dalla fede cristiana è «una crisi di crescita». Il suo collega tedesco Karl Rahner irride la possibilità stessa di poter avere «dopo un anno della geofisica, un anno della fede» e conclude: «Tutto dipende da una riflessione profonda per rendere questa concezione (quella cristiana) credibile per gli spiriti contemporanei». Al Papa che indica di tornare alla Tradizione, di ripetere la dottrina degli apostoli e rimanere in essa, tutti, in fondo, dicono che non basta. La congiura del silenzio che Paolo VI subisce in occasione dell’anno della fede e del Credo del Popolo di Dio manifesta qual è la vera radice dell’incomprensione, della muta ostilità e delle contestazioni sempre più frequenti che il Papa subirà all’interno della Chiesa.
L’idea che il pontificato montiniano abbia subìto a partire dal ’67-68 un’involuzione deludendo le speranze iniziali diventa tanto diffusa nell’intellighentia clericale da essere evocata a metà degli anni settanta da un relatore ufficiale, lo storico Franco Bolgiani, al convegno ecclesiale su Evangelizzazione e promozione umana, davanti a tutti gli stati maggiori della Chiesa italiana.
Il 29 giugno 1972, nell’omelia per la solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo, Paolo VI riconosce: «Credevamo che dopo il Concilio sarebbe venuta una giornata di sole per la storia della Chiesa. È venuta invece una giornata di nuvole e tempeste, di buio, e di ricerche e di incertezze, si fa fatica a dare la gioia della comunione».
A quei tempi pochi osavano testimoniare pubblicamente la devozione e la solidarietà verso un papa irriso anche nei convegni ecclesiali. Tra questi, il patriarca di Venezia, Albino Luciani. La sua omelia pronunciata il 18 settembre 1977 al congresso eucaristico nazionale di Pescara è un’appassionata scelta di campo, un’esplicita dichiarazione di comunione nei confronti del grande Papa di tempi così difficili: «Il Pietro che abbiamo sentito nel Vangelo vive oggi nella persona di Paolo VI suo successore. Ma di Paolo VI ce ne sono due: quello che abbiamo visto iersera qui a Pescara, che si vede e si ascolta nelle udienze generali e private e quello che descrivono, alla loro maniera, inventando e stravolgendo, certi libri e giornali. Vero, autentico, è soltanto il primo: un grande papa, al quale è toccato di svolgere l’alta missione in tempi difficili…».
tratto da: http://trentagiorni.tripod.com/articoli/it-199709-3a.htm